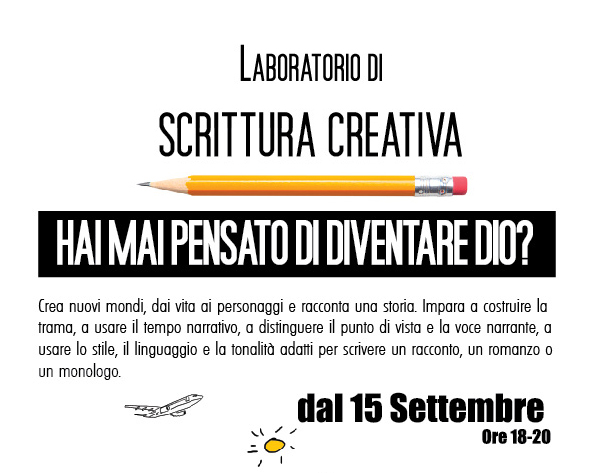L’Italia è una repubblica fondata sul potere delle caste. I cervelli non fuggono dall’Italia, come spesso si sente dire erroneamente, fuggono dagli italiani. Fuggono da una classe dirigente inadeguata, che esercita il potere con arroganza e incompetenza su una sudditanza addormentata. Fuggono dalla mediocrità di un Paese in cui la cultura e la conoscenza sono considerati disvalori e l’approssimazione, l’arrivismo, l’arroganza e le opinioni personali vengono considerati un valore. Se vogliamo trattenerli, e dare una speranza alle generazioni che verranno, c’è poco da fare, bisogna cambiare radicalmente la cultura massonica, clientelare e baronale in cui siamo immersi. Il potere uccide l’iniziativa e la creatività delle menti brillanti. Le spegne. Spegne le idee, l’entusiasmo e la buona volontà. Livella tutto e tutti verso il basso, affinché la mediocrità si vesta di eccellenza. Un lavoratore ha due alternative: adeguarsi o andarsene. Calvino, nel libro Le città invisibili, sosteneva che l’inferno è qualcosa che viviamo ogni giorno stando insieme: possiamo scegliere di farne parte fino al punto di non vederlo più o, scelta ben più difficile, cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio. Che tradotto in termini lavorativi significa restare o andarsene. Ma come siamo arrivati a questo punto? A dire il vero, l’attuale condizione l’aveva prevista con largo anticipo Platone, descrivendo il mito della caverna. Ricordate la storia dei prigionieri nati incatenati in una caverna e costretti a guardare le ombre della vita vera, che scorre alle loro spalle, proiettata su una parete da un enorme fuoco? La pubblica amministrazione è esattamente così, un posto in cui la percezione distorta della realtà viene rappresentata come l’unica verità possibile. E quali sono le ombre “parlanti” proiettate nella caverna della PA dal fuoco, che in questo caso simboleggia il potere? Sono le carriere dei mediocri costruite ad arte da altri mediocri a colpi di meriti immeritati e titoli inverosimili. Sono i vincoli burocratici di ogni tipo e le regole assurde che penalizzano il merito e favoriscono il demerito. Sono le dinamiche dell’Ufficio favori, quello che esisteva una volta nei ministeri e che è cambiato soltanto nel nome e non nella sostanza. Sono i concorsi truccati da un apparente rigore a cui non crede più nessuno. Sono le guerre tra poveri, che si contendono miserie di ogni tipo. Sono i diritti che vengono proiettati nella caverna sotto forma di privilegi, tra il malcontento e l’invidia di chi non può usufruirne e la malafede di chi ne approfitta. Sono gli interessi personali, che prevalgono sugli interessi collettivi. Sono le decisioni immobili, quelle che farebbero bene alla collettivita e invece restano là, appese, sospese e mai prese perché chi è pagato per decidere, nella pubblica amministrazione, fa tutto tranne prendere decisioni importanti che non abbiano altro obiettivo se non il profitto personale. Sono gli obiettivi miseri ingigantiti come le ombre della caverna e le logiche “make or buy”, che sarebbe meglio chiamare “buy or buy”, perché non serve più studiare un problema e trovare le soluzioni adeguate, se si possono acquistare soluzioni costosissime che fanno “quasi” tutto quello che serve e a volte vengono acquistate preventivamente senza nemmeno avere un problema da risolvere. Sono i giorni persi non per lavorare, ma per creare le condizioni affinché si possa lavorare. Sono i fallimenti di chi resta sempre impunito, perché chi sbaglia, nel pubblico, non paga mai, semmai riceve un premio. Capita, però, che un prigioniero riesca a rompere le catene, esca dalla caverna e si accorga che esiste il sole. Inizialmente resta accecato, ma poi riesce a vedere posti nei quali la cultura è un valore e il merito non è una menzogna rimpallata tra la dirigenza e i sindacalisti. Vede posti in cui le idee, le buone idee, da sole bastano per avere “i mezzi e le chiavi del laboratorio”, senza dover aspettare le concessioni da parte di qualcuno che prima o poi chiederà qualcosa in cambio, fosse anche l’attribuzione indegna di meriti che non gli appartengono. Vede i giganti su cui Newton si è appoggiato per guardare più lontano e il rispetto il pensiero e la condivisione dei benefici. Il cervello fugge perché si rende conto di poter essere libero, libero da un sistema malato e illusorio che prosciuga gli animi e riduce a zero le aspettative. A volte capita anche che il cervello libero torni nella caverna per raccontare cosa c’è fuori e dare la stessa opportunità di libertà agli altri prigionieri, quelli che non hanno catene reali, ma sono schiavi della narrazione distorta frutto di quell’unica realtà che vedono e nella quale credono ciecamente. Le ombre sono l’unica verità che conoscono e rappresentano le vere catene da cui non si può scappare. Uscire dalla caverna e guardare il sole richiede uno sforzo troppo grande per gli occhi abituati al buio. Significa rischiare e affrontare il cambiamento. Significa contaminarsi, accettare le diversità degli altri, esporsi a rischi e delusioni. Si dice che i canarini nati in gabbia non sappiano cosa significhi volare, e per le persone è più o meno così: un cervello nato in gabbia non sa cosa significhi pensare. Restare nella caverna significa rinunciare al pensiero e alla ragione: alcuni (per fortuna) non resistono. E sono tanti i cervelli che non ce l’hanno fatta a resistere e hanno lasciato la caverna: più di 800.000 in dieci anni, secondo l’Istat. Ognuno porta via qualcosa, poco importa se sia un brevetto rivoluzionario o la ricetta della pizza napoletana: ogni italiano emigrato è una piccola parte del Paese persa per sempre. È una sconfitta che non può essere giustificata in nessun modo, se non attraverso l’amara consolazione che quel pezzo “buono” d’Italia non viene perso, ma contamina altre culture e in qualche modo rende giustizia ai volenterosi che restano: agli eroi malpagati che fanno turni massacranti nelle corsie degli ospedali, agli idealisti ostinati che passano la vita nei laboratori, ai rassegnati nei corridoi dei ministeri e agli ingenui che pensano di cambiare le cose, illudendosi di far volare i canarini nati in gabbia.