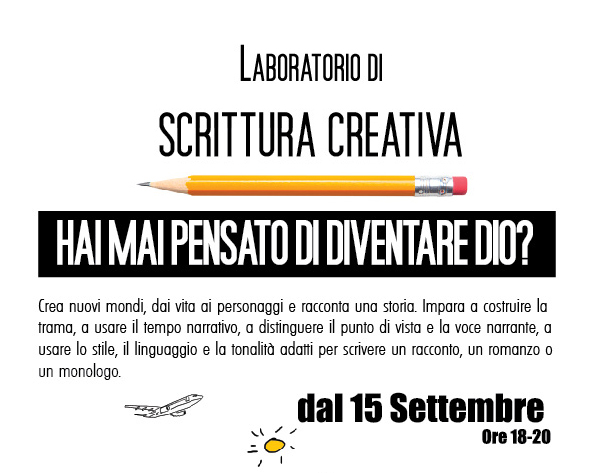In principio era il papiro. Per quasi quattromila anni è stato l’unico materiale attraverso il quale scrivere e tramandare la storia dell’umanità. Nell’anno 105 d.c., in Cina, Ts’ai Lun trovò il modo per fabbricare, «con vecchi stracci, reti da pesca e scorza d’albero », un nuovo materiale scrittorio agevole da produrre e da utilizzare, di basso costo e alla portata di tutti: la carta, chiamata in cinese «Tche ». Si trattava di un’invenzione eccezionale e rivoluzionaria che, come spesso capita, non venne compresa immediatamente. Nonostante gli evidenti limiti del papiro (la difficoltà di produzione, la fragilità, la deperibilità, l’impossibilità di realizzare libri), la carta impiegò oltre mille anni, anche grazie all’invenzione della stampa a caratteri mobili, per diventare il materiale principale attraverso cui è stato possibile condividere la cultura e renderla disponibile a tutti. I detrattori della carta furono molti e la resistenza al cambiamento si protrasse nei secoli. La paura di passare al nuovo materiale venne supportata da affermazioni prive di fondamento: la carta è più fragile del papiro, è difficile da produrre, è più deperibile, è sensibile all’umidità… e così via fino ad arrivare alla peggiore delle chiusure mentali: “Si è sempre fatto così, funziona e non c’è motivo di cambiare”.
Questo meccanismo di protezione è sempre efficace, dà sicurezza, trova spesso un’ampia schiera di sostenitori e frena inevitabilmente il miglioramento delle condizioni umane. Se la carta non avesse avuto il sopravvento, i Philosophiae Naturalis Principia Mathematica di Newton li avrebbero letti in pochi e la teoria della gravitazione universale sarebbe rimasta nascosta chissà per quanto tempo. Del resto, lo stesso ragionamento fu fatto negli anni ‘70 da chi sosteneva che i floppy disk erano meno sicuri della carta, inadatti a conservare le informazioni, poco pratici, inutilizzabili senza un personal computer a portata di mano, etc. Il papiro e il floppy disk, oggi, sono accomunati da un elemento nostalgico: resistono simbolicamente attraverso ciò che hanno rappresentato per l’uomo. In inglese la carta si chiama ancora “paper”, in francese ‘papier’, e per salvare un documento si fa clic su un’icona che rappresenta un floppy disk. Internet e il web sono l’equivalente moderno della carta e del floppy: negli ultimi anni sono stati i principali attori di una rivoluzione epocale, che ha avviato un cambiamento culturale talmente radicale da rivoluzionare il modo di agire e di pensare dell’umanità. Il cambiamento culturale ha obbligato la tecnologia ad adeguarsi, non il viceversa. In poco tempo, si è passati dai personal computer per pochi addetti ai lavori agli smartphone per tutti. La cultura digitale, ben diversa dalle competenze digitali necessarie per utilizzare le tecnologie, è ormai ampiamente diffusa tra la popolazione. Gli acquisti si fanno con un clic e i prodotti si ricevono a casa entro 24 ore, le operazioni bancarie e i pagamenti si fanno con un’app, le indicazioni stradali si chiedono a un assistente dicendo semplicemente “Okay Google, Ehi Siri”. Il fenomeno che chiamiamo “Trasformazione digitale” non è un prodotto della tecnologia, ma un modello culturale che è stato costruito nel corso degli anni attraverso un percorso di crescita collettiva, passato per la condivisione, il benessere e il miglioramento delle condizioni di vita. Proprio come nel caso della carta e del floppy disk.
Se questa considerazione è valida nella vita di tutti i giorni, quando si parla di Pubblica Amministrazione il punto di vista cambia completamente. In primo luogo perché la trasformazione digitale nella PA viene ancora confusa troppo spesso con la tecnologia. Si parla di digital trasformation, facendo riferimento ai servizi in cloud, alla virtualizzazione, ai sistemi iperconvergenti, e si sottovaluta l’aspetto essenziale: la tecnologia è solo il mezzo attraverso cui è possibile attuare il cambiamento. Gli individui, sono loro la componente essenziale della digitalizzazione. Lo sono nella duplice veste di parte attiva e fruitori: da una parte creano gli strumenti e le politiche digitali, dall’altra usufruiscono dei benefici indotti dal cambiamento. I dirigenti della PA, pur essendo nella vita privata i primi fruitori di app, social, Amazon e “Okay Google”, quando si tratta di dare forma a una “cultura digitale aziendale” sono ancora impreparati e resistenti al cambiamento. Hanno paura. Paura di perdere il controllo sugli altri, paura di perdere potere, paura di essere attaccati dai sindacalisti: per questo restano ancorati ai modelli organizzativi militari, che hanno alla base la filosofia del “divide et impera”. Attuano una finta digitalizzazione attraverso l’acquisto di qualche soluzione tecnologica accompagnata da regole spesso inutili, vincoli e paletti burocratici di ogni genere, che rappresentano sempre un mezzo efficace per creare disuguaglianza, ambiguità, competizione tra i lavoratori e malcontenti di ogni genere. La trasformazione digitale non è nient’altro che una trasformazione culturale la cui parola chiave è “condivisione”. Condivisione della cultura, della tecnologia, del benessere, della conoscenza e dei dati. Internet e il web sono nati per questo, per condividere informazioni, e il cambiamento culturale è stato indotto dalla condivisione capillare di conoscenza e servizi attraverso la tecnologia. La condivisione ha portato un livello di benessere elevato e una potenziale consapevolezza mai sperimentata nella storia dell’umanità. Il termine potenziale, quando si parla di consapevolezza, è d’obbligo perché, paradossalmente, l’eccesso di informazioni abbinato a una riduzione del livello culturale si è rivelato molto pericoloso. Il primo problema che dovrebbe affrontare un manager moderno riguarda sicuramente la cultura e la “narrazione” del lavoro a cui i dipendenti pubblici sono da sempre abituati. Sarebbe utile elencare un insieme di comandamenti, per demolire le convinzioni e le convenzioni attuali, ma per ovvi motivi di spazio è sufficiente fermarsi ai primi dieci, anche per non infastidire chi lo ha fatto più di duemila anni fa.
- Perché soffrire al lavoro quando si soffre già abbastanza nella vita?
- Un lavoratore, quando entra in ufficio, ha gli stessi bisogni di quando non lavora
- Ogni lavoratore ha una vocazione, fosse anche mettere lo smalto alle unghie delle formiche
- Controllare il tempo di permanenza in ufficio per dimostrare di aver raggiunto degli obiettivi è utile come pulire le serrande dal polline per risolvere un’equazione differenziale.
- Nella PA il sinonimo di graduatoria è quasi sempre fregatura
- I lavoratori sono contemporaneamente uguali e diversi
- Il senso del dovere non deve essere mai confuso col senso del potere
- Per fare delle scelte bisogna essere consapevoli, per fare degli errori anche.
- Il migliore amico non è mai il miglior dirigente e prima o poi farà pentire il suo protettore di averlo scelto.
- Quando un dipendente pubblico si sveglia, è già nel migliore dei luoghi di lavoro possibili: a casa.
Non è chiaro perché il lavoro, da che mondo è mondo, debba essere accostato alla sofferenza. Il lavoratore pubblico deve soffrire e deve essere punito, non c’è niente da fare, se non altro per essere dato in pasto ai media come simbolo del sacrificio e del riscatto della giustizia sociale. Gli schiavi sulle galee non venivano frustrati e terrorizzati? Sì, lo erano, ma ampi studi hanno dimostrato che la cultura del terrore è controproducente prima di tutto per il datore di lavoro. Dà effetti a breve termine e crea disastri nel lungo periodo che non si possono più riparare. C’è da dire che il datore di lavoro, di solito, si aspetta che un lavoratore smetta di essere un individuo e indossi la maschera disumana di un automa asessuato, senza bisogni, problemi e debolezze; ma quale luogo, se non il posto di lavoro, si presta meglio per manifestare i bisogni, le debolezze, le frustrazioni, le meschinità, le aspirazioni e tutte quegli aspetti che rendono la vita impossibile a chiunque? Si può chiedere a una madre o a un padre di far finta di non avere figli e di dedicarsi al lavoro senza il pensiero degli orari, della spesa, della scuola e della cena da preparare? Ed è possibile che vengano effettuate ancora scelte inique e clientelari, basate esclusivamente sulle simpatie personali, ignorando completamente i dati? Sì, è possibile perché i manager pubblici continuano a essere inadeguati, poco formati e senza una visione chiara di cosa fare e come farlo: Ignoranti quem portum petat nullus suus ventus est (Per chi non sa in quale porto dirigersi, nessun vento va bene – Seneca). Si va avanti ciecamente a colpi di regole insensate e autoritarie, di burocrazia e di regolamenti privi di logica, che non tutelano né il lavoro, né il lavoratore e nemmeno il datore di lavoro. Gli unici a essere tutelati da questo modo incosciente di gestire il lavoro moderno sono proprio i dirigenti, classe inattaccabile, irremovibile e incontestabile per definizione. Si continua a parlare di modelli lavorativi ampiamente superati in ambito privato, di orari di lavoro improbabili partoriti da menti stanche e inadeguate, che ragionano come se la comunicazione tra lavoratori avvenisse ancora attraverso la corrispondenza portata dal “camminatore” da una stanza all’altra. È esattamente questo modello di subcultura che bisogna sovvertire, per cambiare le cose. Lo si può fare soltanto sostituendo la subcultura con la cultura digitale. E attraverso i dati. Quei dati che le pubbliche amministrazioni usano in percentuali molto basse (si stima che i dati “visibili” siano il 15% del totale) e che sarebbero preziosi per prendere decisioni consapevoli.
Un esempio immediato di “logica data driven” da applicare alla Pubblica Amministrazione riguarda senza dubbio i dipendenti. Se è vero che gli individui sono il cuore della trasformazione digitale, è anche vero che in ogni amministrazione pubblica è possibile integrare diverse fonti dati che comprendano le competenze, la professione svolta, il curriculum vitae, le attitudini, i processi lavorativi, gli obiettivi e i risultati, i percorsi di carriera e le situazioni di disagio dei lavoratori.
Basterebbe partire dall’insieme di queste informazioni, analizzare i dati e avere una visione chiara del personale per pianificare la formazione, i piani di fabbisogno, la mobilità, gli avanzamenti di carriera e le procedure concorsuali. È altresì vero che i maggiori ostacoli alla trasformazione digitale sono riconducibili alla scarsa conoscenza dei processi lavorativi e alla disorganizzazione, che spesso costringono i dipendenti pubblici a fronteggiare le emergenze piuttosto che a rispettare una precisa pianificazione a cui siano collegati degli obiettivi da raggiungere. Non è un caso se le principali competenze richieste alla dirigenza siano relative all’intelligenza emotiva, ovvero alla capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo consapevole le proprie emozioni e quelle degli altri. Questa caratteristica è essenziale per favorire il benessere personale e aziendale, per migliorare i processi di comunicazione, la gestione dei problemi e dei conflitti, e la capacità di prendere decisioni ai vari livelli di responsabilità.
Tra le principali competenze richieste alla dirigenza della PA, molte delle quali riconducibili all’intelligenza emotiva, ci sono:
- Mettere al centro gli individui nelle strategie aziendali
- Sperimentare ed esporsi a eventuali fallimenti
- Creare le condizioni organizzative per ridurre i conflitti e motivare il personale
- Investire in cultura e formazione digitale
- Avere una visione di medio/lungo periodo
- Individuare e risolvere le criticità nei processi lavorativi
- Pianificare le attività e gli obiettivi
- Individuare gli strumenti migliori per attuare i cambiamenti
- Favorire il benessere organizzativo
- Monitorare i processi, misurando il raggiungimento degli obiettivi
Le competenze digitali diventano fondamentali quando il cambiamento culturale è stato avviato. A quel punto si può parlare di DNA digitale, di soft skills e di hard skills. Ma questa è un’altra storia.
Alessandro Capezzuoli