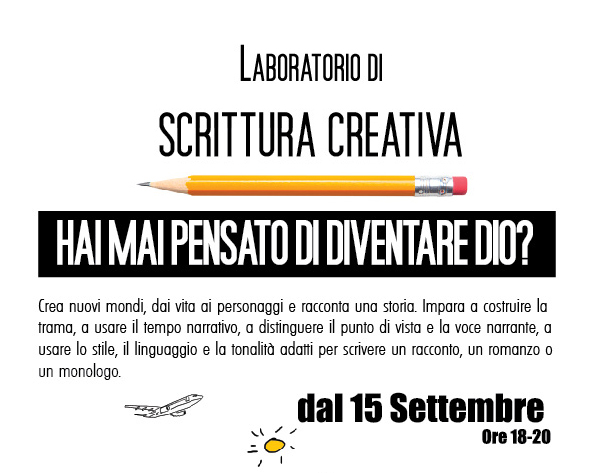Ama il potere come te stesso, questo è stato per quarant’anni l’unico comandamento della religione di Fabio Duranti. Una religione che, a dire la verità, trova da sempre un ampio numero di fedeli. Il potere, non il lavoro: la differenza è sostanziale. Se si fosse dedicato anima e corpo a un lavoro appassionante, forse sarebbe riuscito a dare un senso alla sua vita. Invece, in quell’ultimo giorno di lavoro, non riusciva a vedersi in un altro posto che non fosse il suo ufficio all’ultimo piano del Ministero dell’Economia. Temporeggiava, metteva negli scatoloni ricordi inutili, che sarebbero rimasti chiusi là dentro per l’eternità e non avrebbero alleviato quell’angoscia che si impossessa immediatamente dei pensionati appena mettono il naso fuori dall’ufficio. L’attimo prima e quello dopo il pensionamento spezzano l’uomo in due. Dividono il suo senso di utilità dal disagio dell’inutilità, la partecipazione dall’isolamento, le aspettative dalla rassegnazione. Fino al momento dei saluti ti senti parte di un mondo, dopo diventi un estraneo. Ti ritrovi solo, con troppo tempo disponibile e pochi modi per riempirlo. Smarrito come Pollicino nel bosco, con una sensazione di vuoto simile a quella che si prova dopo aver scartato i regali di Natale, a causa della consapevolezza di aver consumato non la festa ma la sua attesa. Le parole di Fabio, che risuonavano come ordini perentori per i corridoi del ministero, sì erano sgonfiate negli ultimi mesi: ormai non incuteva più timore quasi a nessuno. Non pensava che sarebbe toccato anche a lui, rifiutava l’idea. Il potere è per sempre, pensava. Dare ordini, questa era la sua fissazione. Giusti o sbagliati che fossero. Anzi, più le sue decisioni erano ingiuste, più umilianti erano le conseguenze, e più si sentiva onnipotente. Come quella volta in cui riuscì a obbligare i dipendenti a prendere dei giorni di ferie forzate in prossimità delle feste comandate, facendo credere ai superiori che si trattasse di una misura necessaria per risparmiare. Il risparmio era quasi pari a zero, ma il piacere che provava in quell’esercizio di prepotenza era immenso. Il risultato fu duplice: da una parte la rivolta dei dipendenti e dall’altra le lodi dei superiori. Che tradotto nel suo linguaggio significava colmare i sensi di inferiorità di cui soffriva da sempre e mettere un altro mattoncino per arrivare a far parte della schiera dei superiori. Quel ricordo, per un momento, lo fece sentire soddisfatto di sé: lui era diventato un “superiore”. Di cosa e di chi non aveva importanza, la cosa importante era avercela fatta, aver scalato tutti i gradini della carriera. La ragione della sua esistenza era tutta in quel ruolo: direttore generale. Il senso del dovere l’aveva sostituito da subito col senso del potere e nessuno si era potuto sottrarre alla realtà che lui aveva deciso di raccontare agli altri. Rispetto di regole assurde, colpi bassi e meschinità varie erano entrate anche nelle vene anche dell’ultimo usciere. Costruendo una realtà distorta, aveva intossicato l’ambiente giorno dopo giorno, subdolamente, come chi avvelena l’acqua con l’obiettivo di avvelenare le persone. L’ultimo provvedimento che aveva firmato avrebbe preso forma l’indomani, attraverso la nomina del successore: l’unico che era rimasto fedele. Si sentiva orgoglioso di essere stato duro e spietato fino alla fine.
– È stato stronzo fino alla fine.
– La nomina di Marchetti se la poteva risparmiare. D’altronde, dopo anni di scelte a cazzo, non poteva che terminare in bellezza.
– Poi, proprio Marchetti, che ne ha dette sempre peste e corna. È arrivato perfino a dire che si scopava la moglie… lo chiamava l’impotente prepotente.
– Fatti loro, io so solo che non sono riuscito nemmeno a fare un misero passaggio di fascia e lui avrà una pensione coi fiocchi.
– Ci mancava pure la pagliacciata della festa di pensionamento: me la risparmierei volentieri.
– Dai, scendiamo, ci sarà anche Marchetti, che è più stronzo di lui: se non vede che ci siamo anche noi chissà che pensa.
In una sala enorme, tristemente addobbata con qualche decorazione, si era creato un viavai di persone che mangiavano un tramezzino, scambiavano qualche parola e salutavano, alcune timidamente, altre con rancore, il direttore uscente e, soprattutto, quello entrante.
Poi fu il momento del discorso.
– È con immenso dispiacere che…
Il dispiacere è solo suo, pensava la platea annoiata.
In meno di un’ora era tutto finito: il personale era tornato ad occupare le stanze e lui era uscito per sempre da quell’edificio, portando via due scatole di cartone e un senso di sconfitta che non aveva mai provato prima. Non aveva più nessuna scadenza, niente di urgente da firmare e nessuna questione essenziale da risolvere: tutto ciò che riteneva l’essenziale era alle sue spalle, nelle stanze anonime dell’edificio che, dopo aver girato l’angolo, non vedeva già più.
Non c’erano più scuse.
Non poteva più rimandare.
Non poteva più raccontare e raccontarsi false verità, come aveva fatto per anni, avvelenando gli altri e sé stesso, in cerca di una ragione o di una scusa che desse senso alla sua esistenza. Le scuse erano tutte in quelle scatole piene di vuoti. Doveva fare i conti con quello che non era mai stato e cominciare a essere. Ed era difficilissimo.
Alessandro Capezzuoli