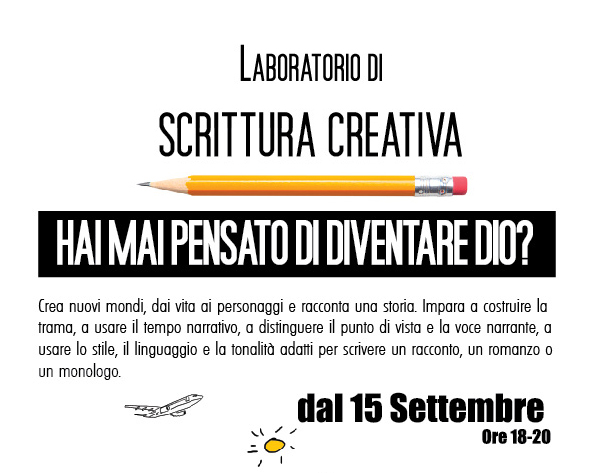Quand’è che ho iniziato a sentirmi geneticamente inadeguato alla vita? Dunque, vediamo… a pensarci bene, credo che la battaglia contro l’inadeguatezza sia iniziata da subito, nello stesso momento in cui la mia testolina si è palesata a quella grandissima testa di minchia del ginecologo di mia madre. Diciamo la verità, all’inizio di questa storia ho fatto un po’ lo sborone: ho parlato di carpiati e di uscite trionfali ed eleganti, ma in realtà avevo deciso in tempi non sospetti, più o meno da quando ero uno spermatozoo vagabondo, che non avrei abbandonato quella casa calda e accogliente, nella quale non pagavo le tasse, il vitto e l’alloggio erano gratis e, soprattutto, lo spazio era insufficiente per ospitare altre persone oltre al sottoscritto. Avrei lottato con ogni mezzo a mia disposizione, per rendere la vita difficile a qualsiasi figlio di puttana avesse avuto intenzione di sfrattarmi. Così, il giorno dello sfratto, mi sono ancorato con tutte le mie forze a qualsiasi organo trovassi lungo il periglioso viaggio verso l’uscita. Ho fatto un po’ come quei disgraziati che si legano a un termosifone pur di non abbandonare la casa occupata abusivamente. Non avendo termosifoni a disposizione, però, ho usato quello che ho potuto, fino all’ultimo penoso tentativo di legare il cordone ombelicale al rene di mia madre. Niente, quel grandissimo cornuto la sapeva lunga e, quando ha visto che opponevo resistenza, non ha esitato a infilare le mani dove nemmeno mio padre aveva osato, per cercare di tirarmi fuori. Non aveva previsto di trovarsi davanti a un osso duro, però, e non aveva nemmeno previsto il fallimento del ravanamento uterino. E allora cosa si è inventato? Ha preso una specie di ventosa e mi ha risucchiato fuori con la stessa grazia con cui un idraulico stura un cesso. Il risultato è stato una deformazione permanente del cranio ben visibile, che e mi fa rispondere con un bel “Fatti i cazzi tuoi” a chi mi chiede “Ma cos’hai sulla testa?”. Complimenti, professorone, bel lavoro! È chiaro che se uno nasce in questo modo non può essere ben disposto verso il prossimo. Oltretutto, quel genio di ginecologo, un po’ perché era incazzato, un po’ perché ero rimasto senza fiato all’idea di avere la scatola cranica deformata a vita, ha iniziato a darmi una raffica di schiaffi sul culo per sincerarsi che fossi vivo. Sia chiaro, non ho pianto come tutti i bambini, la mia era una contestazione anarchica vera e propria. Urlavo e mi dimenavo come per dire : “Lasciatemi libere le mani che a questo lo sfonno”. Rideva, il coglione, e non c’è niente che mi faccia imbestialire più di un coglione che ride quando sono incazzato nero. Soprattutto se sono nato da poco. Come dire… sto al mondo da dieci minuti e già l’umanità mi sta sul cazzo.
Dopo quell’esordio in grande stile, come ho accennato nelle pagine precedenti, le cose sono considerevolmente peggiorate: non poteva essere altrimenti. Anche perché ero ignaro dei genitori che la sorte aveva deciso di assegnarmi: i più poveri e mal assortiti che potessero esistere. Mio padre non era povero, era un aspirante ricco con ambizioni e manie di grandezza esagerate a cui dava seguito facendo ricorso a stravaganti bizzarrie. Che so, invece di comprare una villa sull’Appia antica, prendendo in subaffitto una stanza in un seminterrato delle case popolari di Piazza Capecelatro. Alfonso Capecelatro, per l’esattezza, un toponimo scelto appositamente per rappresentare degnamente un luogo di merda, che tuttora è composto nemmeno da una piazza vera e propria ma da una specie di slargo occupato in gran parte da una chiesa e contornato da casermoni popolari fascisticamente squadrati. Ora, capisco la voglia legittima di nascondere la ricchezza esagerata, che solo un lavoro umile, umiliante e malpagato può dare, capisco pure la stravaganza di preferire un seminterrato umido in una squallida periferia a un ambiente lussuoso e confortevole, ma, santo cielo, proprio la Palerma ci doveva capitare? La Palerma, per quei due o tre che non la conoscessero, è stata la donna più maliziosa e peccaminosa di sempre, colei che ha dato un senso alla teoria di Darwin e che, secondo gli esperti, rappresentava l’anello di congiunzione tra il mandrillo e il capitone. Non ho mai capito perché fosse soprannominata Palerma, dal momento che non era siciliana e aveva uno spiccato accento abruzzese; forse perché in quegli anni i viaggi erano considerati un evento eccezionale e i soprannomi venivano affibbiati sulla base dei luoghi visitati. Alla Palerma andò di lusso, nel palazzo c’era anche Furbara, che poi tanto furba non era, e Gnocca, colei che ebbe la disgrazia di visitare l’omonima città e di beccarsi questo soprannome in onore della sua cessitudine. Tornando alla Palerma, poiché condividevamo la stessa casa, non potevo fare a meno di assistere a scene che mi hanno causato enormi dubbi sull’identità sessuale. È mai possibile che una donna possa radersi tutte le mattine una barba folta che parte da sotto gli occhi e arriva fin dove non oserebbe battere il sole nemmeno se ne avesse la possibilità? Non sarebbe stato meglio soprannominarla, che so, Frate Indovino? A quanto pare no, e la barba non era nemmeno il suo peggior difetto. Di errori il creatore ne ha fatti parecchi, ma credo che la Palerma sia stato il suo sbaglio migliore, quello di cui andare fieri. Quell’errore che si ammette, dopo anni di negazionismo, una sera a cena con gli amici, tra un bicchiere di Amarone e una pinta di birra. Per fortuna, guardando oltre l’aspetto fisico, nel tempo ho scoperto anche lati peggiori: la capacità di litigare col marito, soprannominato la bestia, utilizzando un gergo da camionista indiavolato, peraltro molto educativo per un ragazzino di pochi anni. Le liti erano un crescendo di insulti, che abbracciavano tutte le sfumature di luoghi in cui andare a far visita e coprivano almeno tre archi generazionali con cui prendersela. Che soddisfazione, sentirli litigare con vernacolare passione: molto ma molto meglio dei film trash degli anni ‘80, ai quali sono approdato già svezzato, con un dizionario di idiomi ben nutrito. Comunque, la cosa che più mi stupiva di quelle liti non erano tanto i reciproci insulti, quanto il gesto finale della Palerma: messa in scena di suicidio a base di simulazione di avvelenamento da candeggina, che fingeva di bere da un fiasco di vino. La prima volta confesso di averci creduto. Si era accasciata per terra e si contorceva dai finti dolori come un tonnetto appena pescato. Venne addirittura la guardia medica, la quale, dopo essersi accertata che l’alito sapeva di carbonara e non di candeggina, andò via incazzata. La scena del finto suicidio si verificava con cadenza settimanale, ma una volta ci fu il colpo di scena: lei uscì di casa sbattendo la porta, senza fingere l’avvelenamento, e la bestia, deciso a ubriacarsi, scambiò il fiasco di vino Cacchione di Nettuno col fiaschetto in cui la Palerma conservava la candeggina. Ne bevve una sorsata a garganella e finì in ospedale. Se la Palerma fosse riuscita a far fuori il marito in questo modo, sarebbe stato un vero e proprio capolavoro da inserire nei manuali di criminologia. Invece, dopo l’incidente, si limitò a mettere in giro la storia che il marito aveva tentato il suicidio per amor suo. Storia che la bestia smentì ampiamente in diverse occasioni. Non vi nascondo che quel fatto turbò notevolmente l’armonia della convivenza forzata e diede a mio padre un forte impulso per cercare non tanto un alloggio popolare quanto una raccomandazione per ottenerlo. Aveva poche risorse per corrompere i funzionari dell’Istituto Case Popolari, ma le utilizzò tutte e alla fine riuscimmo a entrare in graduatoria. Non sto qui a raccontare i festeggiamenti conseguenti alla pubblicazione delle graduatorie, è più interessante soffermarsi sulle bestemmie che tirò giù mio padre, quando apprese l’esito della visita dell’ispettore incaricato di rilevare la nostra situazione patrimoniale. Mia madre, donna di una lungimiranza sconfinata, per intenerire l’ispettore, ostentò più povertà di quanto fossimo in grado di dimostrare. Disse di non avere nulla: niente istruzione, niente soldi, niente prospettive, niente speranze. Solo miseria. Triste, irrecuperabile e sconfinata miseria. Riuscì perfino a dichiarare il falso, giurando e spergiurando che mio padre fosse disoccupato e che per tirare avanti chiedeva aiuto al parroco della chiesa di Santa Maria della Salute. E quello, giustamente, dopo un primo momento di empatia, si infastidì al limite dell’incazzatura e fece una relazione in cui dettagliò l’inadeguatezza patrimoniale in cui versava la nostra famiglia e la conseguente impossibilità di onorare il pagamento del canone mensile. Devo ammettere che quel senso sopraffino per gli affari, che mi ha reso tristemente noto, non è merito del mio intuito, semmai è una preziosa eredità materna che custodisco gelosamente come la colatura di alici di Cetara. Al momento giusto… zac!, mi avvento come una iena sull’affare che ho fiutato e faccio puntualmente la minchiata. Sono un collezionista seriale di fallimenti.
Che poi, se proprio devo essere sincero, un fondo di verità nelle parole di mia madre c’era eccome, perché il parroco spesso ci aiutava come poteva: a volte con qualche vestito usato, altre volte con qualche pacco di pasta, E chi se lo scorda, padre Manganello… Sì, lo so, prima Don Prudenzio e adesso Padre Manganello: d’altronde non è colpa mia se ho avuto una madre chiesolica, aggettivo coniato dal sottoscritto per descrivere i fedeli scaramantici che credono contemporaneamente in Gesu Cristo, nei maghi e nella chiesa cattolica bigotta. Padre Manganello sembra un nome inventato di sana pianta, ma si chiamava proprio così: Alfio Manganello. Non ho mai capito se fosse il vero cognome o una specie di nome d’arte. I preti, si sa, sono un po’ come gli attori: si immedesimano nella parte, ci credono, recitano un copione collaudato e ogni messa è un successo assicurato come i cinepanettoni. Il pubblico, fortuna loro, è ammaestrato da secoli di lavaggi del cervello, quindi non rischiano nemmeno recensioni negative su Famiglia Cristiana. Fatto sta che quel nome, scelto dal destino o dall’interessato, era quanto di più azzeccato ci potesse essere. Almeno quanto Patty Pravo al posto di Nicoletta Strambelli.
Padre Manganello era palesemente fascista, ma talmente fascista che si faceva il segno della croce invocando il nome del Padre con un gesto… come dire… alla larga, tendendo la mano a mo’ di saluto romano, e ripetendo lo stesso gesto per scambiarsi la stretta di mano coi fedeli in segno di pace. Scambiarsi un segno di pace partendo dal saluto romano è come carezzare il prepuzio con la carta vetrata. Esiste poi un’altra versione sull’origine di quel soprannome, sulla quale però non ci sono fonti certe: i ben informati sostengono che ad averlo coniato sia stata proprio la Palerma, successivamente a una relazione sacrilega avuta con lui. Incautamente, si era lasciata sfuggire una confessione a una riservatissima fedele: “Ce l’ha come un manganello”. A parte la raffinatezza della metafora, supponendo che non si riferisse al naso e che la tesi fosse confermata da un rigoroso processo di revisionismo storico, ci sarebbe da intraprendere azioni energiche per estendere il segreto della confessione anche ai fedeli, non solo ai preti: i rischi a cui si va incontro durante una qualsiasi confessione possono essere elevatissimi…
Tuttavia, la supposta deviazione reazionaria è confermata anche da un’altra evidenza: la fondazione dell’ordine dei crociatini di Padre Manganello, un gruppo di ragazzini dell’oratorio, esaltati come gli Harlem Globetrotters, che, a differenza di questi ultimi, erano bassi, non giocavano a pallacanestro e avevano una divisa imbarazzante composta da una calzamaglia bianca e da un mantello azzurro. Durante le celebrazioni liturgiche, sfilavano con il piglio dei supereroi tra i banchi della chiesa, e io morivo dalla voglia di far parte del loro gruppo. Prima di considerare l’appartenenza a qualcosa o a qualcuno un disvalore, c’è voluto parecchio tempo: da ragazzo avevo un bisogno disperato di essere notato, di esistere in funzione dell’esistenza degli altri. L’appartenenza ai crociatini di Padre Manganello sarebbe stata la mia grande occasione, per mostrare a tutti che esistevo: per fortuna le mie richieste vennero rifiutate più volte con sdegno. La verità è che ho speso una buona parte della vita per appartenere a un gruppo, a un’ideale o a una donna e poi, quando ho capito quali e quante prigioni si nascondono nelle appartenenze, ho faticato tantissimo per diventare un uomo libero. Detta così, può sembrare che abbia buttato la mia vita nel cesso, e in effetti non si tratta di un’impressione, è proprio così: appena mi sono liberato dalle prigioni che mi sono costruito con le mie mani, son stato emarginato ed escluso dalla società che conta, quella che ha bisogno di schiavi servili, fedeli e obbedienti. Il mio disagio, però, non è stato dettato dall’esclusione e dall’emarginazione perpetrate da persone che contavano poco meno della laniccia dell’ombelico, a quello ci si abitua facilmente. Essere straniero in qualsiasi posto, essere diverso e dover scontare i pregiudizi: questo è il fastidio che mi accompagna da sempre. Comunque, quella storia dell’esclusione dai crociatini ancora mi fa rodere il culo, non fosse altro perché, facendone parte, avrei potuto approfondire la questione dell’origine del soprannome “Manganello” e dare informazioni più precise. Poiché il mio senso di inadeguatezza alla vita era opprimente, e non sapevo con chi prendermela se non con me stesso, avevo trovato un modo per sfogare la mia rabbia: camminavo per ore nei prati e arrivavo fino alla ferrovia, un posto lontanissimo da casa e, soprattutto, lontanissimo da tutti. Se ci penso, sento ancora il profumo delle margherite a primavera e l’odore della pioggia sulle foglie secche in autunno. Per non parlare del rosso dei papaveri o dei tramonti dietro ai fili dell’alta tensione, che mi sembravano bellissimi: i più belli che avessi mai visto. Poi c’erano i treni, quei treni che non finivano mai. Mi passavano davanti agli occhi a tutta velocità, per andare chissà dove, e io stavo là, seduto in mezzo all’erba, a fantasticare sulle vite di persone immaginarie. Inventavo storie assurde, le scrivevo e arrivavo sempre a una conclusione: la mia infelicità aveva una causa. I responsabili erano quei personaggi di fantasia, che avevano vite bellissime a mio discapito. E io li odiavo. Su quei treni viaggiavano, insieme alla gente, tutte le opportunità a cui ambivo, se ne andavano lontano e io ero seduto in quel prato e non sarei mai riuscito a raggiungerle. Cosa poteva aspettarsi, d’altronde, un ragazzino di periferia a cui il destino aveva riservato un’esistenza triste dentro a un seminterrato buio nelle case popolari di Piazza Capecelatro? Non lo sapevo, ma in quei lunghi giorni, in cui ero solo con le mie paure, stavo costruendo l’uomo che sarei diventato. La mia inadeguatezza, diciamolo, spesso era dovuta anche un po’ all’ingenuità che mi portavo dentro e che mi faceva passare per il coglioncello del gruppo. Hai dato fuoco alla fontana con un cerino spento, adesso chiamiamo la polizia e ti facciamo arrestare, mi dicevano i crociatini di Padre Manganello. No, non sono stato io, lo giuro, non chiamate la polizia, vi prego. E giù risate. E giù pianti. Più piangevo impaurito e più ridevano. E correvo via con tutto il fiato che avevo in corpo. Fuggire, quella era la soluzione. Le fughe solitarie, a cui mi abbandono anche adesso per salvaguardare quel poco che è rimasto del bambino che ero, mi hanno insegnato ad ascoltare il silenzio e a cercare di capirne i mille significati. I silenzi non sono tutti uguali, c’è voluto un po’, ma alla fine l’ho capito. E io, modestamente, ho sperimentato tutti ti tipi di silenzio. Ho cominciato coi silenzi semplici, quelli dettati dall’imbarazzo: sto zitto perché non trovo le parole. O le ho finite. Poi sono passato ai silenzi dignitosi, quelli in cui semplicemente non avevo nulla da dire. Ho perso il conto degli esami a cui mi sono sottoposto, avendo a disposizione soltanto il silenzio come arma. Da una parte c’ero io, dall’altra il carnefice pronto a pontificare un qualche tipo di giudizio. E io spesso questa soddisfazione al carnefice non gliel’ho data. Ho taciuto. L’ho lasciato a bocca asciutta e col suo bel giudizio appeso. E i silenzi saggi? Ah, che bellezza! Quei bei silenzi in cui avrei voluto vomitare fuoco e fiamme, dire con furore “Non capisci proprio un cazzo, è giusto che qualcuno te lo dica!”, ma poi mi sono reso conto che non ne valeva la pena e ho fatto la cosa migliore: sono stato zitto. Poi ho sperimentato anche il silenzio protettivo, se ci penso mi faccio tenerezza da solo. Scegliere con cura le parole che possono ferire e non dirle. Cancellarle. Ometterle e sostituirle con altre più dolci, più rassicuranti, più curative. E accorgersi che la cura fa effetto, che il viso di chi ascolta si illumina e non si spegne. Mi vergogno un po’, ma spesso sono ricorso anche al silenzio cattivo, quello indifferente, per esprimere disprezzo e lontananza. Ma i silenzi peggiori in assoluto, quelli che mi hanno consumato a poco a poco i sentimenti puri e immacolati che avevo, sono stati i silenzi rumorosi. Quelli parlati. Quelli in cui sono stato costretto a riempire i vuoti e le distanze incolmabili tra me e chi mi stava di fronte con parole frugate a caso nel copione della commedia che stavo recitando. Le ho pronunciate contro la mia volontà, Signori Giurati. Mi sono violentato, mi sono sforzato per fingere meglio e dare la falsa impressione di essere presente. E gli altri ci hanno creduto. Uh, sì, eccome se ci hanno creduto. Commentavano. Controbattevano. Si sentivano chiamati in causa. Attori di uno spettacolo in cui pensavano di avere il ruolo del protagonista. Invece, lo spettacolo, per me, era finito già da un pezzo. Ma i presunti protagonisti si ostinavano, rivendicavano il loro ruolo. Pretendevano persino di convincermi che, No, non è così come credi, stai sbagliando. Loro protagonisti, io comparsa. Ruoli invertiti. E io semplicemente non ero là, non stavo parlando. Non avevo mai parlato. Non avevo detto niente. Non avevo più niente da dire. Volevo solo scappare, essere altrove. Non io, il cuore, l’anima. Cancellare tutto. Tornare indietro o andare avanti, non aveva importanza, ma in un posto lontanissimo da quel discorso assurdo che non avrei mai voluto fare. Che tristezza. Che dolore. Che sofferenza. Non sarà mai più come prima. Sarà qualcos’altro. Sarà qualcun altro. Saranno parole diverse e silenzi diversi. Mai più questo silenzio rumoroso. Mai più. Io comparsa di oggi, lei attrice di ieri. Dio, quanto mi sono immedesimato in quella canzone di Lucio Battisti. Che ne hanno mai saputo le persone di me? Di un ragazzino che, sul serio, mica come la finzione della canzone, giocava nel buio, si vergognava, era timido, vedeva i raggi di sole che trafiggevano le inferriate di un buio seminterrato e camminava solo fino alla ferrovia, fino a perdersi nel silenzio di quei prati immensi. Quello sì che era un silenzio vero. Puro. Il silenzio dell’innocenza. Lo stupore di fronte all’immensità dei prati e della solitudine.
Poi tornavo a casa e la realtà si palesava ai miei occhi in tutta la sua brutalità.
– Ndó sei stato fino adesso, brutto fijo de ‘na mignotta? Me farai morì, te pozza scoppià lo core.
Di quanta dolcezza era capace mia madre? Che poi, se vogliamo essere precisi, dare del figlio di mignotta a tuo figlio non è esattamente una mossa azzeccata. È come fare involontariamente coming out. In ogni caso, queste erano le parole accoglienti che mi riservava mia madre quando rientravo. Non capiva il dramma interiore che vivevo, ma non gliene ho mai fatto una colpa. Capisce l’inadeguatezza soltanto chi sa di cosa si parla, probabilmente le persone semplici non provano quel fastidio di sentirsi sempre nel posto sbagliato. O meglio, forse non provano la sensazione di sentirsi sbagliati. Mi sentivo sbagliato rispetto a cosa? Rispetto a tutti gli altri, che sembrano più intelligenti, più belli, più felici, più socievoli, più sicuri. E rispetto a quei dogmi precostituiti che vengono coltivati in quel luogo di perdizione chiamato famiglia. È là che vengono costruiti i pregiudizi, le inibizioni, la paura della diversità, il senso di inferiorità, l’esaltazione della competizione e dell’arrivismo. È la che inizi la tua personale battaglia contro il figlio della portiera, che gioca a calcio e ha un futuro brillante chissà in quale squadra, o con tuo cugino, che è tanto bravo, ha tutti 9 a scuola mentre tu sei una pippa a giocare a pallone, perdipiù hai la media del 2,74 e non fai un cazzo dalla mattina alla sera. Nessuno racconta mai tutta la storia con sincerità, perché probabilmente sono in pochi a conoscerla. Nessuno dice che il figlio della portiera, o il cugino con cui sei stato in competizione e che ti ha rovinato l’esistenza, nella maggior parte dei casi non combina mai niente e diventa un anonimo fattorino insoddisfatto, pagato 2 euro a consegna. Mentre il perdente, il solitario, quello strano, il fallito assicurato che non avrebbe mai combinato niente di buono, riesce se non altro a diventare un uomo. Anche se deve far ricorso a tutta la forza e all’energia che ha in corpo. Capirlo non è facile e nemmeno scontato. Devi arrivare ad avere almeno mezzo secolo sulla groppa, avere la cervicale e, cosa fondamentale, aver sprecato quasi tutte le opportunità che avevi, grazie a una serie infinita di minchiate che hai dovuto commettere per forza, per uscirne vivo. Quando l’hai capito, tendenzialmente è tardi. Almeno per me è stato così. Non ho potuto far altro che rimpiangere tutte le alternative che avevo lasciato andare a seguito di una qualche scelta. Il problema non è la scelta ma sono le alternative che si escludono quando si sceglie. Tu scegli di fare un certo tipo di studi e poi, quando non è più possibile tornare indietro, ti accorgi che c’erano decine di argomenti che ti sarebbero interessati di più. Poi inizi a lavorare, per mettere su casa, per avere dei figli, una famiglia, e ti rendi conto ben presto che hai bruciato tutto il resto. Hai bruciato la possibilità di vivere in altri posti o di avere altre donne, magari migliori, magari peggiori, chissà… Hai bruciato la possibilità di fare altri dieci, cento, mille lavori diversi e di metterti ogni volta alla prova. E devi fare i conti con la persona che non sei diventata. Non sei diventato il musicista che sognavi, o la ballerina, o il pittore. Non sei diventato il vagabondo, il solitario in barca a vela, l’attore o lo speaker radiofonico. E sai perché? Perché hai scelto, e ogni scelta nasconde una qualche prigione da cui diventa difficilissimo uscire. Per uscire dalle prigioni che ciascuno si cuce addosso, e diventare finalmente persone libere, bisogna essere disposti ad affrontare prove dolorosissime che non hanno mai vincitori. Bisogna mettere in discussione tutto, gli affetti, i valori bell’e pronti, le soluzioni a portata di mano, gli amici, la famiglia, e sentirsi dire, Sei cambiato, accettando il colpo serenamente, parando l’accusa con un bel, Ho avuto il coraggio di diventare quello che sono. E come si fa a diventare quel pittore che hai dentro? E io che ne so? Sono l’ultima persona a cui chiedere le ricette di un qualche tipo di ambizione. Io ho fallito, ho mancato il successo. Anzi, il successo ha mancato me. O, meglio, ci siamo schivati. Ci stiamo sul cazzo a vicenda. Lui perché ha come target tutti quelli che nella vita ho sempre evitato, i sicuri, gli ambiziosi, i materialisti, i superuomini che considerano essenziale tutto ciò che io ritengo privo di senso, spreco di tempo: lo status, la ricchezza, il potere, un ruolo di comando. Insomma, il successo ama quelle persone che, viste coi miei occhi, come dire… credono di essere ‘stocazzo e in realtà sono più insignificanti della birra analcolica o della mortadella di soia. Il mio contenzioso col successo è iniziato da quando, a forza di letture, disillusioni e delusioni, ho maturato un briciolo di consapevolezza e ho capito più o meno cosa è importante e cosa non conta niente. È la consapevolezza che mi ha fatto accumulare il tempo per stare con la donna che amo, magari a passeggiare sulla spiaggia, quando tutti si affannano a rincorrere il nulla, in una fredda giornata d’inverno. Dalla consapevolezza al disprezzo delle glorie da stronzi, per parafrasare Guccini, il passo è breve. Ma come, io che non permetto a nessuno di esercitare su di me nessuna forma di potere dovrei ambire a rendere schiavo qualcun altro, per sentirmi importante? Sarebbe come dire “Sono comunista” e poi votare per la Lega. Eppure, non c’è niente di più equo e ben ripartito, tra uomo e donna, di quell’’ingannevole desiderio di esercitare il potere sugli altri, per dimostrazione al mondo, dal vivo, non solo attraverso la tastiera di un computer, le merde che siamo. Una coppia, in fondo, altro non è che un sistema chiuso in cui ci sono un controllore e un controllato, in perenne lotta per trovare e mantenere un qualche tipo di equilibrio. Equilibrio che è sempre talmente instabile da andare in frantumi al primo alito di vento primaverile. Spesso, la parte del controllore è assegnata alla donna, ma sono molto frequenti anche le situazioni opposte. A me è sempre capitata la prima. All’inizio c’era una lei che voleva me. Nel mezzo c’era una lei che non voleva esattamente me, voleva qualcosa che aveva in mente e che aveva proiettato su di me. Praticamente ho sempre vissuto nell’illusione di essere l’uomo giusto quando in realtà ero un punto di vista sbagliato. La cosa grave è che mi sono quasi sempre impegnato a diventare quel punto di vista, cedendo alle estenuanti prove di forza e alle trattative al ribasso. Mi chiedo come mai, dopo i primi tempi, si arrivi sempre alla deriva illusoria del cambiamento. Voglio te, ma tu devi diventare come dico io. Come dire, voglio una Panda, ma pretendo che diventi come una Mercedes. Ma, cazzo, non fai prima a comprarti una Mercedes? No, perché la Mercedes non posso permettermela. Se non puoi permetterti una Mercedes, è inutile che ti ostini a pensare che io abbia i sedili massaggianti in pelle: eppure ho sempre messo le cose in chiaro fin dall’inizio. Ho dei sedili sgangherati, rivestiti con un motivo messicano terribile, che si sconocchiano dopo i primi cinquemila chilometri e fanno un avvallamento al centro che favorisce la comparsa delle emorroidi. Invece, nonostante la chiarezza, la presa di coscienza non c’è mai. Sì consumano vite intere a cercare di trasformare un finestrino a manovella in un silenziosissimo finestrino elettronico. Che poi, è tutto da dimostrare la supremazia della Mercedes sulla Panda. Consuma di più, costa un sacco in manutenzione, si svaluta tantissimo, si rompe né più né meno come l’altra e alla fine ti porta esattamente negli stessi posti. Senza considerare le prove di resistenza coronarica a cui ti sottopone ogni volta che compare un graffietto sul paraurti. Questione di punti di vista, quindi. La verità è che non sono nato Mercedes, non lo sono diventato, e tutto sommato ne sono anche contento. Ho provato a esserlo, questo è vero, ma il risultato non è stato proprio soddisfacente. Da ogni esperienza ho sempre cercato di uscirne migliore, ma il problema è che sono diventato una Panda, col cofano di una BMW, le portiere di una Mercedes, i sedili di una Palio, il design di una Duna, il motore di una Dacia Sandero e le prestazioni di un Ciao senza variatore. Detto così può sembrare un disastro, in realtà quei pezzi “diversi” donati generosamente dagli altri sono stati i libri che non avevo letto, le canzoni che non avevo ascoltato, i baci che non avevo dato, i piatti che non avevo mai cucinato, i pomeriggi che non avevo vissuto: un tesoro di esperienze sistemate come meglio potevo e a cui ho cercato di fare spazio. Fatto sta che le estenuanti trattative, le liti, i musi lunghi e le accuse reciproche non hanno mai sortito l’effetto sperato, proprio perché gli spazi occupati influenzano fortemente quelli rimasti liberi o perché, se proprio devo cambiare, cambio come e quando dico io.
In tutto ciò, l’unica certezza che ho maturato è questa: non c’è nulla di più pericoloso dell’ambizione al possesso delle cose o delle persone. Che poi, diciamo la verità, più che il possesso delle cose a me interessa il possesso del tempo per fare delle cose. Magari per diventare quel musicista o quel cuoco che ho dentro e che ha bisogno di tutt’altro, per uscire allo scoperto. Oppure per cazzeggiare in giro, inseguendo la famosa libellula in un prato, possibilmente evitando di entrare a far parte di quel mondo di ciechi che ambiscono a una pensione di invalidità piuttosto che al recupero della vista.
Poiché i metodi tradizionali hanno dimostrato ampie fragilità, nel dubbio, ho deciso di non fare più scelte nette e di puntare a vivere tutte le alternative che una scelta porta con sé. Scelgo le alternative e scarto la scelta. Le scelgo tutte. E non mi sottraggo ai dubbi. Dubito e mi interrogo, quando tutti sono sicuri e vanno avanti come branchi di cefali. Ho imparato a dubitare di tutto e in qualsiasi momento: del mio lavoro, della donna che ho accanto, delle maggioranze, della religione e pure dei crociatini di Padre Manganello. Un giorno, in una delle tante fughe dalla cattiveria che solo chi crede in un qualche dio è capace di esercitare, mi sono chiesto
-Ma veramente voglio far parte di quel gruppo ed essere come loro?
La risposta ovviamente non poteva che essere negativa. Ho avuto un attimo di smarrimento, mi sono sentito perso: era crollata la certezza che mi aveva accompagnato per molto tempo. Si era frantumato l’obiettivo della mia infanzia come un bicchiere infrangibile che, quando si rompe, si rompe in milioni di schegge che vanno a infilarsi ovunque. Ne ho vissute altre, di queste delusioni, ci sono state altre bande, altri leader, altre persone, giovani e anziane, con cui ho desiderato far bella figura, fino ad arrivare a una conclusione: di cosa pensano gli altri sul mio conto non me ne frega più un’emerita cippa.
La domanda che mi pongo, a questo punto, è la seguente: “Come ho fatto a diventare quello che sono diventato, a uscire dal tunnel della solitudine e a vincere tutte le timidezze che avevo, trasformandomi magicamente da orso asociale quale ero a cazzone da villaggio turistico?”. Bella domanda… Spontanea. Mi sono colto impreparato e adesso mi tocca improvvisare una risposta. Direi che nella solitudine ci sguazzavo abbastanza bene. Mi ero dato un insieme di regole che ritenevo utili per sopravvivere alla competizione con gli altri e alle umiliazioni delle sconfitte. Ho capito da subito che non ero portato per le competizioni, infatti quelle che ho imprudentemente intrapreso le ho sempre perse tutte. Ho cominciato da quelle scolastiche e ho finito con quelle sentimentali, per conquistare un cuore conteso. Se penso a quanto ho pianto, mi viene da piangere. Certo, vedere scritto su un foglio 1+, il voto ai temi di italiano, con l’aggiunta della frase “il + è d’incoraggiamento”, non mi ha aiutato a vincere le insicurezze. Né tantomeno lo ha fatto la maestra di Italiano, quella volta che mi disse “Strano, lei è autorizzato a copiare dai suoi compagni, tanto non è in grado nemmeno di fare quello”. Poi dici che uno dà fuoco alla scuola e diventa bombarolo. Dicevo che mi sono dato delle regole per superare i miei enormi limiti. La regola aurea, che tra l’altro funziona ancora, è semplice: gli altri possono farmi del male solo se sono io a dargli questo potere. E ritorniamo a bomba sui danni che può fare qualsiasi tipo di potere. Perché do importanza a quello che gli altri pensano di me? Che ruolo hanno gli altri nella mia vita? È proprio necessario viaggiare insieme o meglio soli? Se Socrate non avesse tirato fuori quella storia dei tre setacci, probabilmente avrei avuto un futuro da filosofo, invece, tutto quello che sono riuscito a fare è stato difendermi dei carnefici. Che non è poco. Piano piano li ho allontanati tutti. Tutti tranne un. Ricordo quel giorno di tanti anni fa come se fosse adesso. Pioveva, e io, tanto per cambiare, me n’ero andato a passeggiare nei campi. Non so perché, ma la pioggia mi è sempre piaciuta. Camminare sotto la pioggia, lasciarsi accarezzare. Impossibile sporcarsi, sotto la pioggia. Ha un’azione benefica su di me, più di una doccia dopo una corsa. Insomma, ero là che camminavo con la fretta di chi non può perdersi quel tramonto dietro i fili dell’alta tensione, con il sole che sembra trafigga le nuvole. Se mi dice bene, riesco anche a vedere un arcobaleno, pensavo. Mentre fantasticavo, ho sentito un rumore, una specie di lamento. Poiché conoscevo bene i rumori di quel posto, ho escluso da subito che si trattasse di una volpe o di un cane. C’è qualche intruso che viene a rompere i coglioni proprio qua. Forse qualche coppia che si è infrattata, lontana da occhi indiscreti. Gliela faccio passare io, la voglia… di inquinare il mio paradiso. Insomma, come direbbe Alberto Sordi, mi dirigo come un lumacone, zitto zitto, verso il luogo del misfatto e che ti vedo? Un ragazzino sdraiato a terra.Che ci fai qua? Questo è il mio posto!
-Te lo sei comprato? È anche il mio, di posto…
-Te ne devi andare, questo posto è sacro.
-Mi sono slogato una caviglia e non riesco a camminare. Comunque non me ne sarei andato nemmeno se fossi stato bene.
-Vuoi che chieda aiuto a qualcuno?
-No, lasciami in pace. Voglio morire qui. Da solo.
-Ma non dire stronzate.
Me lo sono caricato sulle spalle e l’ho portato fino a casa. Facendo ricorso a tutte le mie forze. Fermandomi ogni dieci metri, con le gambe che mi tremavano per la fatica. E da quel giorno, i due ragazzini che volevano morire hanno iniziato un cammino lungo e faticoso. Insieme. Hanno condiviso la timidezza e l’inadeguatezza alla vita, cercando di proteggersi a vicenda, sostenendosi a turno, mettendosi ogni volta alla prova per superare quei limiti che sembravano insuperabili. Cercando di avvicinarsi a quel mondo sconosciuto che li attraeva e li respingeva con la stessa forza: l’universo femminile. E hanno condiviso anche quel prato immenso, che era abbastanza spazioso per entrambi e aveva avuto il potere di trasformare due solitudini in un’amicizia eterna. Quel ragazzino era Alberto.