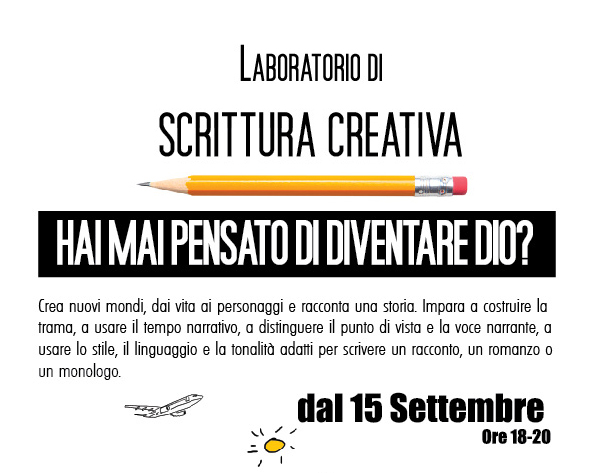Negli ultimi tempi, mi capita spesso di incontrare decisori politici nazionali e locali, per discutere di dati. O, meglio, per discutere di politiche guidate dai dati (data-driven, per chi non abbia familiarità con la propria lingua e, probabilmente, nemmeno con l’inglese). Da questi confronti ne esco sempre più arreso e disilluso, perché non posso fare a meno di prendere atto del decadimento culturale collettivo in cui sono costretto ad annaspare. Mi chiedo se nelle istituzioni si abbia contezza dell’uso imbarazzante, ma sarebbe meglio dire disuso, dei dati che viene fatto dalla politica. Guardando oltre l’utilizzo propagandistico o fraudolento, perpetrato barbaramente sui diversi media, si può ragionevolmente affermare che il senso comune, l’intuito, le convenienze e la malafede guidano le scelte politiche molto più dei dati: in poche parole, a dispetto dei proclami pomposi che si ascoltano nei convegni, non c’è speranza di farcela. Posso fare esempi illustri su questo tema. Supponiamo per assurdo che esista qualcuno talmente folle da essere votato alla demografia e da dedicare la vita allo studio delle minoranze berbere o all’invecchiamento della popolazione. Quali delusioni, quali angosce, quale presa di consapevolezza, nel momento della resa dei conti, rispetto al tempo e alla vita sprecata in cose inutili di cui non importa niente a nessuno, avrebbe quello sventurato, quando si renderebbe conto che, nonostante i suoi anatemi, l’Italia tutto sembra tranne un paese adatto agli anziani? La sanità è inadeguata come e più delle pensioni, il medico di famiglia ormai riceve su prenotazione ed è sempre più lontano dai bisogni di quei pazienti che a volte si recavano dal medico soltanto per sentirsi meno soli, i servizi sono a portata di SPID ma non di ultraottantenne… La verità è che gli anziani vanno piano e la classe dirigente è troppo impegnata ad andare di corsa verso il baratro, per orientare le politiche come “dato comanda”. I vecchi, per il sistema, rappresentano un problema riconducibile quasi esclusivamente alla dimensione economica dell’aspetto pensionistico: poco importa se dietro quel dato sull’invecchiamento si celano vite, solitudini, difficoltà, disperazione e passi stanchi. Quindi, a cosa serve sapere che la popolazione invecchia, se nella pratica non interessa a nessuno creare un Paese a misura di anziano? Un lettore arguto potrebbe osservare che a decidere delle politiche sugli anziani sono quasi sempre quelle persone che vedono la vecchiaia da punti di vista (o età) privilegiati, senza avere la minima consapevolezza di cosa significhi rallentare senza volerlo, avere obiettivi a breve termine, che non c’entrano nulla con la corsa folle del liberismo e dei mercati, diventare fragili, o restare soli, o avere paura per una morte imminente o per la decadenza incombente. Posta in questi termini, la questione delle politiche guidate dai dati potrebbe sembrare rivolta soltanto a una massa di politici insensibili, ignoranti e incoscienti, che non hanno nulla in comune con i dirigenti e gli specialisti illuminati: niente di più falso. Quando si tratta di fare delle scelte, sono proprio quei dirigenti e quegli specialisti a non credere nei dati che producono e per i quali impegnano una vita intera. Ne è un esempio lampante l’attuazione della trasformazione digitale, o dello smartworking, nella PA. Pur avendo a disposizione informazioni di ogni tipo, che vanno dai profili del personale alle indagini sul benessere, dai dati sugli spostamenti a quelli sull’inquinamento, dai processi produttivi alle spese di gestione, non ho ancora incontrato un decisore o uno specialista che abbia seriamente preso in considerazione l’idea di pianificare il lavoro consapevolmente, attraverso un’analisi seria delle informazioni: lo smartworking viene ancora applicato sulla base di quelle stolte linee guida, scritte nel consueto delirio di onnipotenza punitiva dall’ex Ministro Brunetta, e la trasformazione digitale viene applicata “a sentimento”, sulla base di convinzioni e investiture di onniscienza egoriferite. Il risultato è palese: se negli anni ‘80, per rinnovare un documento d’identità, bastava recarsi nell’anagrafe di zona, adesso bisogna avere il dito più veloce del west, per prenotare un appuntamento in date imprecisate, dopo aver effettuato l’autenticazione a due fattori con SPID (specialità in cui gli anziani primeggiano da sempre). L’ultimo confronto esilarante a cui ho partecipato ha riguardato proprio l’oggetto di questo articolo: la questione migranti. Su questo tema, l’atteggiamento della politica è da sempre ben peggiore di quello riservato all’invecchiamento, forse perché la diversità continua ingiustificatamente a impaurire le persone molto più della vecchiaia. Il nodo cruciale della discussione riguardava gli sbarchi e quel mezzo miliardo di euro da investire nei prossimi cinque anni, in quell’impresa folle dei centri di accoglienza albanesi.
Mezzo miliardo di euro… il tipico esempio di come si possa sperperare del denaro pubblico, in azioni inutili e inefficaci, quando le decisioni non sono guidate dai dati ma dalla pancia e dall’ultimo tratto dell’intestino crasso. Quel mezzo miliardo, ho pensato, sarebbe stata la cifra giusta per dar seguito a un progetto di qualche anno fa, di cui discutemmo durante un convegno riguardante il Sistema Informativo sulle Professioni e che aveva una diapositiva con sopra scritto “Formiamoli a casa loro”. Prima di descriverlo, però, ci tengo a fare una piccola precisazione sul mio modo di intendere gli esseri umani. Confesso di avere una particolare avversione rispetto ai “metodi tradizionali” con cui si affrontano i fenomeni migratori, non fosse altro perché ho ben chiaro che le origini delle migrazioni risalgono alle popolazioni di cacciatori-raccoglitori, e al consumo di territorio necessario alla sopravvivenza, per i quali l’ultimo dei pensieri era sapere quanti egiziani ci fossero a Brembate di Sopra (anche perché gli egiziani ancora non erano stati inventati). In generale, la conta degli esseri umani mi è sempre sembrata una pratica al limite del disumano, che ricorda la gestione dei pollai e gli allevamenti intensivi. L’unica differenza tra gli animali e gli esseri umani è che a nessun pollo verrebbe mai in mente di contare quanti altri polli ci sono in un pollaio, suddividendoli per razze e provenienze, con il solo scopo di decidere chi abbia il diritto accoppiarsi con le galline più belle, chi debba cibarsi col granturco migliore e chi debba finire in un forno o in un tegame, per essere cucinato arrosto, alla diavola o alla cacciatora. Tuttavia, non posso non prendere atto che, in quest’epoca di pazzi, non mancano gli idioti dell’orrore e che, per vivere in armonia nei paesi civili, è vitale sapere quanti siamo “noi” e quanti sono “loro”. Se, nonostante il censimento, le rilevazioni socioeconomiche e l’anagrafe centralizzata, i dati continuano a essere totalmente ignorati e le politiche data-driven continuano a essere pressoché inesistenti – i giovani si ostinano a voler emigrare ancorché i dati si ostinino a dire che i giovani si ostinano a emigrare-, nei confronti dei flussi migratori la situazione è ancor più grottesca.
Faccio un esempio pratico, così mi spiego meglio, e poi prometto di arrivare al nocciolo della questione. Sappiamo che i bangladesi in Italia sono circa 150.000 (frutteria in più, frutteria in meno) e che a Roma, dove vengono chiamati affettuosamente “bangla”, ne risiedono circa 33.000 (minimarket in più, minimarket in meno). Questo numero solitario dice poco o niente; al limite, viene usato nei talk show per far dire a qualcuno che Roma è invasa dai bangla. Per farlo parlare, bisognerebbe far ricorso a quella dote rara e preziosa che si chiama senso critico e contestualizzarlo rispetto a numerose altre variabili, ma non è questa la sede per farlo. Qui possiamo limitarci a connotare superficialmente la dimensione del fenomeno e a dire che a Caserta, una città di circa 70000 abitanti, un numero di bangladesi così alto cambierebbe completamente il tessuto sociale: significherebbe che quasi un abitante su 3 sarebbe bangladese.
E a Roma?
Lo stesso, perché, come dimostrano i dati, le modalità con cui, dal pleistocene in poi, i migranti occupano i territori sono ben precise e non prevedono una distribuzione uniforme nello spazio e nel tempo. Nel caso dei bangladesi, complici i prezzi degli immobili più contenuti, è accaduto che una percentuale importante si sia insediata nel quadrante Prenestino-Centocelle, in un’area che conta circa cinquantamila abitanti. Chi risiede in quella periferia ha vissuto e subito una trasformazione totale del quartiere: la maggior parte delle attività commerciali è cambiata (come è accaduto con la comunità cinese all’Esquilino), il mercato rionale ha chiuso, sono cambiati i riti collettivi, le usanze e le abitudini. Sono cambiate le relazioni, i culti religiosi, il modo di fare la spesa e di educare i figli. Di conseguenza, servirebbero dei servizi differenti, delle scuole adeguate, una politica di integrazione e non di ghettizzazione, insomma, servirebbero delle scelte guidate dai dati, affinché la presenza dei bangladesi non venga percepita come un’invasione o, peggio, come il furto dell’identità collettiva (che non si sa bene cosa sia, dal momento che la collettività cambia continuamente e non ha un’identità stabile). A questo punto, una domanda sorge spontanea: “A cosa è servito quel numero, quel 33000, alle amministrazioni locali che si sono succedute?”. Assolutamente a nulla, esattamente come i dati sull’invecchiamento. Le cose sono andate come dovevano andare, cioè governate dal caso e dalla necessità, senza uno straccio di programmazione, Più che dai dati, le scelte sono state guidate da Tyche e Ananke, come avrebbero spiegato efficacemente i greci.. Anche in questo caso, se dietro quel numero ci fosse stato lo spreco del mio tempo di vita, avrei provato un senso assoluto di disagio e di inutilità, misto a rabbia e frustrazione. Forse, qualunque sia il lavoro da svolgere, sarebbe il caso di tornare a porsi le tre famose domande esistenziali tanto care ad Heidegger:
Che cosa sto facendo?
Perché lo sto facendo?
Per chi lo sto facendo?
Anch’io, ormai molto tempo fa, mi sono illuso di avere una risposta rassicurante a questi quesiti, che giustificasse il mio sforzo sovrumano, per guardare laddove non era facile vedere: poi sono guarito…
Ma andiamo con ordine.
Mezzo miliardo di euro è un bel gruzzolo con cui si potrebbero attuare delle politiche sulle migrazioni efficaci e misurabili, perché basate sui dati.
Su quali dati? Sui dati del Sistema Informativo delle Professioni.
Continuo a sostenere che, nonostante sia diventato maggiorenne, è ancora l’unica esperienza di cooperazione (umana e applicativa) tra istituzioni che prosegue proficuamente da oltre vent’anni senza attriti e conflitti. Già questo – unito alla professionalità, alla passione di chi ci lavora, alla collaborazione, al rispetto, alla qualità dei dati, alla raffinatezza tecnologica – sarebbe sufficiente a far prendere in seria considerazione una gestione razionale delle politiche attive sul lavoro basata su questo strumento.
Basterebbe organizzare alcune azioni scomposte in un flusso organizzato e consapevole, partendo dal nodo centrale: i fabbisogni di personale.Ebbene sì, il “nostro” mercato del lavoro ha bisogno del “loro” aiuto per continuare a essere sostenibile. Unioncamere, partner storico del Sistema Informativo sulle Professioni, ha rilevato che nel 2022 le entrate di personale immigrato previste dalle imprese sono state 922 mila (nel 2021 erano state 671mila), si evidenzia quindi un incremento notevole rispetto all’anno precedente in cui la richiesta di personale immigrato si era già riportata al di sopra dei livelli pre-covid.
Le entrate di personale immigrato sono aumentate del 47% (+295 mila unità in valori assoluti) sul 2019. La domanda di lavoratori immigrati registra inoltre un ritmo di crescita più elevato rispetto a quello che ha interessato il totale dei contratti di assunzioni programmati (pari a +12% tra il 2019 e il 2022).
Oltre a questa osservazione, all’interno delle schede provenienti dall’indagine Excelsior, e collegate al Sistema Informativo sulle Professioni, viene misurata la difficoltà di reperimento delle singole professioni (Categorie della Classificazione CP2021). Questo significa che, per ogni Categoria, è possibile conoscere non solo il fabbisogno espresso da parte delle imprese e la relativa difficoltà di reperimento, ma anche i dati ISTAT sull’occupazione provenienti dall’indagine sulle Forze Lavoro, i dati INPS sulle retribuzioni di ingresso e i dati INAIL sulle malattie professionali e sugli infortuni (dati peraltro essenziali anche per pianificare le politiche riguiardanti la sicurezza sul lavoro). L’INAPP, inoltre, fornisce una descrizione dettagliata della professione, elencandone i compiti e le caratteristiche, che, nel caso di professioni tecniche o a elevata specializzazione, può essere integrata dai dati Almalaurea provenienti dall’indagine sulla condizione occupazionale dei laureati.
Si tratta di un ricco patrimonio pubblico, una vera rete Linked Open Data, che non ha eguali nel resto del mondo. Per fare un esempio pratico, possiamo prendere come riferimento i falegnami. Unioncamere ci dice che c’è un’alta difficoltà di reperimento di questa professione (64%), causata per il 57,2% dalla mancanza di personale, dal 34,1% da una preparazione inadeguata e per la restante parte da altre cause. Ci dice inoltre che il numero di migranti necessari al fabbisogno, rispetto al totale delle entrate (20500), è pari al 16,8%.
L’INAPP ci dice quali compiti sarà chiamato a svolgere il lavoratore, misurandone l’importanza e la complessità.
mentre l’Istat rileva l’andamento dell’occupazione e le sue caratteristiche.
L’INPS ne misura la retribuzione d’ingresso
e l’INAIL dettaglia approfonditamente la natura e le caratteristiche degli infortuni e della malattie professionali.
Insomma, senza dilungarmi in ulteriori descrizioni, allo stato attuale, un politico volenteroso potrebbe avere la piena consapevolezza dei fabbisogni lavorativi, complessivi e in funzione dei migranti, di quali professioni “andare a cercare”, del loro costo, dei loro rischi e dei compiti che dovrebbero svolgere i lavoratori. Inutile dire che, trattandosi di istituzioni facenti parte del Sistema Statistico Nazionale, tutti i dati garantiscono livelli di qualità elevata, rappresentatività, raccordabilità nel tempo e con le statistiche internazionali.
A questo punto, avendo scelto lo strumento da utilizzare, l’unico veramente efficace per l’attuazione di politiche serie sul lavoro, sarebbe necessario individuare le misure attraverso la quale reclutare i lavoratori nei loro paesi di origine, per “formarli a casa loro”, come sostenevo nella mia diapositiva. Queste misure si chiamano “Centri per l’impiego” e “Certificazione delle competenze”, con un’accezione più ampia rispetto a quella attuale. Per il momento, terrei da parte il mercato del lavoro riguardante le professioni – tecnicamente Unità Professionali – di livello medio-alto (contenute nei Grandi Gruppi I-II e III della CP2021), perché bisognerebbe introdurre un ulteriore livello di complicazione che riguarderebbe i percorsi di formazione e il riconoscimento dei titoli di studio, che andrebbe approfondito in una pubblicazione specialistica. Mi soffermerei quindi sulle professioni meno qualificate, riferite ai gruppi IV-V-VI-VII e VIII della CP2021.Il Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze, con il suo Atlante delle Professioni, seppur a mio parere scientificamente inadeguato a descrivere e regolamentare il mercato del lavoro nella sua interezza, può essere particolarmente utile ed efficace in casi circoscritti, specialmente se abbinato a interventi di formazione volti a garantire uno sbocco occupazionale concreto e a misure politiche di sostegno. Certo, un’operazione di questo tipo comporterebbe l’istituzione di Centri per l’impiego nei Paesi esteri e un lavoro diplomatico consistente per definire gli accordi e le modalità di attuazione.Poi, servirebbe una certa concretezza nella qualità delle qualificazioni certificate e dei percorsi di formazione, affinché le imprese si “fidino” di un’attestazione rilasciata dai diversi enti titolari e non subiscano l’imposizione di lavoratori inadeguati. Ci sarebbero sicuramente difficoltà burocratiche da superare, contratti e tutele da garantire e questioni logistiche da affrontare, che richiederebbero un investimento cospicuo di risorse.
Mezzo miliardo in cinque anni, per l’appunto.
Utopia?
Certo, perché nell’epoca dei pazzi non mancano gli idioti dell’orrore.