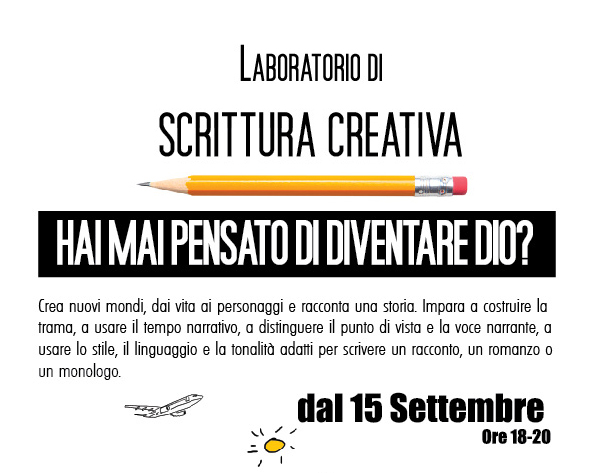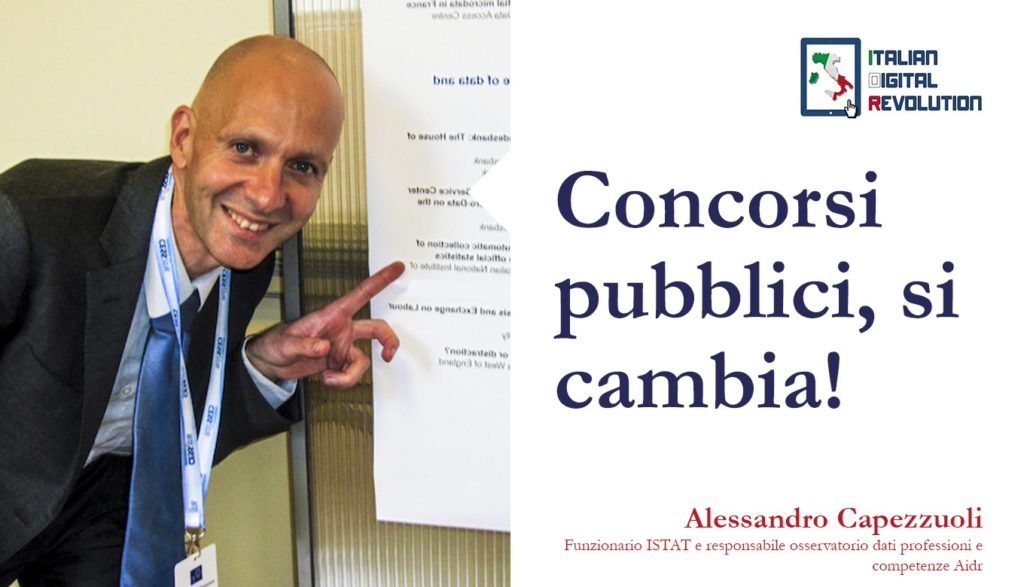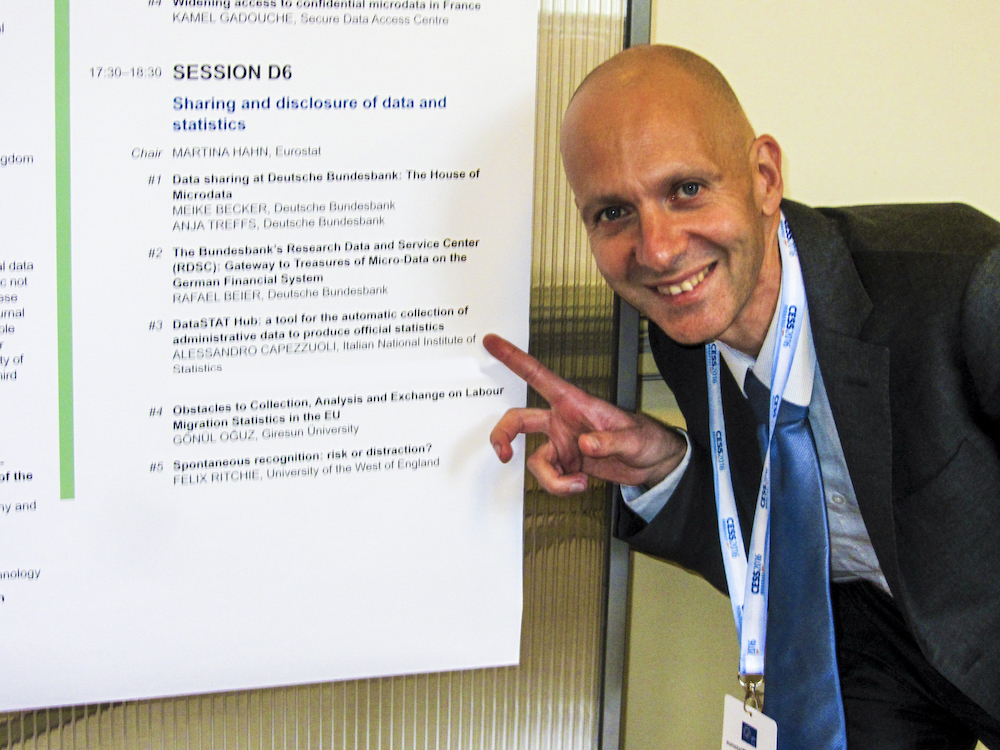L’opinione è uno dei mali peggiori che affligge la cultura moderna. Per costruire un’opinione, non serve nessun talento: basta leggere superficialmente qualche notizia e trarre conclusioni affrettate e imprecise. Per costruire una cultura, invece, è necessario studiare un argomento in profondità. Per costruire una cultura collettiva, oltre a una buona dose di pazienza e di utopia, occorrono tempo e condivisione. Il diritto all’opinione è diventato sacro, talmente sacro da lasciare poco spazio alla cultura. L’Italia ormai è un Paese basato sulle opinioni; ovunque è pieno di opinionisti da bar, esperti all’occorrenza di virus e di fisica nucleare, che tendono a ridicolizzare, o, peggio, a banalizzare qualsiasi concetto richieda un’analisi approfondita Si potrebbe dire che la professione attualmente più diffusa sia l’Esperto di opinioni. Recentemente, mi sono imbattuto in un articolo scritto da un sociologo, che rimproverava uno storico per aver fatto riferimento a dei “non meglio precisati fatti storici”. Lo storico in questione era Alessandro Barbero, uno che di storia… come dire… ha dimostrato di saperne qualcosina. Sicuramente ne sapeva più dell’opinionista in questione. Lo smart working, al pari di numerosi altri temi che ho trattato in passato, non fa eccezione: sono bastati pochi mesi per costruire milioni di esperti di lavoro agile e di organizzazione del lavoro, che in realtà ne sanno ben poco, ma dispensano consigli e pareri. Esperti che sono passati da anni e anni di lavoro dietro alla scrivania alla formulazione di teorie sullo smart working. L’emergenza sanitaria ha dato una forte spinta verso lo smart working, ma, paradossalmente, ha anche dato una forte spinta verso il ritorno in presenza. Semplicemente perché la tipologia di lavoro attuata in questi mesi non è stata affatto smart; si è trattato perlopiù di un telelavoro, spesso disorganizzato e attuato con mezzi di fortuna, attraverso il quale è stato possibile proseguire numerose attività, spostando di fatto la postazione lavorativa dall’ufficio alle case dei dipendenti. Eravamo pronti? Forse. Sicuramente non lo erano tutti i lavoratori e non con quel metodo. C’è da dire, però, che il lavoro pubblico è rimasto imbalsamato per decenni in un regime di telelavoro assistenziale, da cui avrebbe dovuto trarre insegnamento, dispensato sulla base delle graduatorie, delle disgrazie e dei favoritismi. Poi c’è stato (e c’è) il POLA, che avrebbe dovuto dare una spinta verso l’attuazione del lavoro agile. Insomma, sulla carta avremmo dovuto essere pronti da un pezzo, nei fatti, in molti casi, siamo stati colti di sorpresa e abbiamo improvvisato soluzioni di fortuna. Il Ministro per la Funzione Pubblica, in una recente intervista, ha definito il telelavoro emergenziale come “lavoro a domicilio all’italiana”: si tratta, a parer mio, di un’opinione spericolata simile a quella del sociologo citato all’inizio dell’articolo..Ci sono centinaia di numerosi esempi virtuosi che hanno dimostrato palesemente l’efficacia di questo “prototipo” di lavoro agile, e che, seppur tra numerose contraddizioni, ha migliorato l’organizzazione del lavoro e la produttività in molte istituzioni. Uno scenario simile, meriterebbe una forte accelerazione, perché è evidente che non cambiare adesso significherebbe non cambiare più. E a dover cambiare non è soltanto lo svolgimento della prestazione lavorativa; è il consumo delle risorse, è la spesa pubblica, è il modo di vivere le grandi città, è il modo di spendere il tempo e di spendere il denaro, è l’economia delle periferie e dei piccoli centri. Lo smart working porta con sé una serie di ricadute positive sulla collettività che non possono essere ignorate.
Prima di addentrarci nei nodi irrisolti, che giustamente devono essere affrontati e migliorati, è utile richiamare brevemente i pilastri fondanti della filosofia smart. Filosofia tutt’altro che attuale, dal momento che risale addirittura agli anni ‘70. Diciamo subito che lo smart working non è una modalità di erogazione della prestazione lavorativa, è un modello organizzativo della società in cui il benessere dell’individuo, inteso come parte integrante della collettività, prevale sulla sofferenza lavorativa, e conseguentemente esistenziale, del lavoratore. Proprio perché un lavoratore fa parte della collettività, il benessere dei singoli individui, attraverso lo smart working, diventa benessere collettivo. In altre parole, favorire il benessere dei lavoratori significa favorire il lavoro. Questo concetto semplice semplice è difficile da far digerire all’opinione pubblica, che, da sempre, preferisce sadicamente un lavoratore vessato e sofferente. Il bene più prezioso che hanno gli esseri umani, benché si cerchi continuamente di dimostrare il contrario, non è il denaro bensì il tempo. Lo smart working consente ai lavoratori di spendere il tempo nel modo migliore possibile (e di continuare a spendere il denaro nel modo peggiore possibile). Cosa è accaduto in questi mesi di emergenza? È accaduto un fenomeno che probabilmente, tra qualche anno, verrà studiato sui libri di storia: il malessere collettivo ha prevalso su qualsiasi forma di benessere individuale. Il tempo a disposizione è stato più che altro una collezione di minuti tutti uguali, di confinamenti, di momenti di paura e di interminabili comunicati televisivi in cui i temi principali erano la morte e il terrore. La collettività è stata disgregata e la diffidenza verso il prossimo ha prevalso sulla fiducia. Il prossimo è diventato potenzialmente pericoloso per la salute pubblica e i comportamenti altrui, anche i più innocui, sono diventati lesivi per la collettività. Questa evidenza è sempre stata sotto gli occhi di tutti: guidare in modo spericolato o sversare rifiuti tossici nelle falde acquifere è una colpa ben più grave rispetto a una corsetta senza mascherina. Eppure il sentimento di diffidenza verso il prossimo alimentato dalla pandemia ha prevalso sul buon senso ed è tuttora dilagante.Sfiducia, teniamo a mente questa parola. Venendo meno il tempo e il benessere, il lavoro agile ha perso la sua natura: più che lavoro a domicilio è diventato jail working, una specie di reclusione lavorativa che non c’entra nulla con l’idea originaria. E su questo il Ministro Brunetta non ha torto: il lavoro agile ha bisogno di un’organizzazione diversa. Ha torto quando sostiene (o fa finta di sostenere) che i lavoratori pubblici, tutti, indiscriminatamente, hanno goduto di un imprecisato lungo periodo di benessere e per questo devono tornare a soffrire in ufficio. Questo atteggiamento induce a sospettare che l’oggetto del contendere non sia la prestazione lavorativa ma una specie di questione personale tra il Ministro e i lavoratori pubblici. Certo, probabilmente ci saranno state minoranze di lavoratori che hanno approfittato del momento per tirare i remi in barca, ma a chi verrebbe in mente di incendiare una casa per togliere di mezzo un formicaio? Ci sono degli aspetti da migliorare, è vero, ma bisogna ripartire proprio da queste evidenze, per gettare le basi di un’organizzazione del lavoro diversa. In primo luogo è necessario superare la sfiducia collettiva. Lo smart working si basa su un patto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, decadendo la fiducia, decade anche il principio fondante dell’accordo. I cittadini sono sfiduciati, divisi, hanno rancori e malcontenti, spesso giustificati dalla perdita del lavoro, che riversano in modo indiscriminato su coloro i quali stanno meno peggio. Dar seguito a questo sentimento, accontentare l’opinione pubblica, sarebbe come incendiare la casa per accontentare gli inquilini con la fobia per le formiche. Il dipendente pubblico è da sempre un bersaglio privilegiato dell’opinione pubblica, per questo (sarà un caso?) il futuro dello smart working è destinato a seguire due strade diverse. Nell’ambito privato, le aziende hanno capito molto bene di trovarsi di fronte a una delle opportunità più ghiotte degli ultimi anni: il lavoro agile permette loro di ottimizzare i costi e di dismettere le costosissime sedi, mantenendo lo stesso livello di servizio e di produzione. Nell’ambito pubblico, l’esigenza di contenere i costi viene sentita molto meno, forse perché le risorse amministrate non appartengono agli amministratori ma ai cittadini. C’è poi un’evidenza innegabile: se in molte amministrazioni centrali lo smart working ha dato risultati che sono andati oltre le più rosee aspettative, nelle amministrazioni locali la qualità dei servizi ha subito un peggioramento. Il disservizio si è verificato perlopiù in quelle organizzazioni in cui la presenza dei lavoratori a contatto con il pubblico è ancora essenziale. Mi riferisco ai piccoli comuni, ai servizi anagrafici, ai servizi territoriali, insomma, a tutte quelle attività in cui la digitalizzazione è assente. Ed è assente non solo a causa di un ritardo clamoroso delle istituzioni, ma è assente anche per la riluttanza di una parte della popolazione a utilizzare strumenti digitali per usufruire dei servizi pubblici. Più che disinvestire nello smart working, occorrerà investire fortemente in diverse direzioni. In primo luogo nella cultura e nella condivisione dei suoi principi fondanti, ma su questo aspetto, a differenza del passato, una parte della classe dirigente ha preso coscienza delle potenzialità di questo modello lavorativo ed è passata dall’altra parte della barricata, sostenendo, e non più osteggiando, il lavoro agile come modalità di lavoro ordinaria. In secondo luogo, sarebbe opportuno rafforzare le dotazioni informatiche della PA e investire nella formazione digitale dei lavoratori: alcune amministrazioni lo hanno fatto e risultati sono stati sorprendenti. Esiste una questione di natura giuridico-contrattuale, che verrà affrontata nel corso dei prossimi giorni in un tavolo condiviso dal Dipartimento per la Funzione Pubblica e l’Aran: tuttavia, non è l’aspetto contrattuale a preoccupare i lavoratori, semmai è il contenuto del contratto.
Quali sono i punti su cui non si dovrebbe assolutamente tornare indietro? Occorre opporsi fermamente alla reintroduzione delle graduatorie e dei punteggi basati sulle invalidità e sulle esigenze famigliari. Sembra assurdo che si torni ancora a parlare di questa eventualità, nonostante sia stato ampiamente dimostrato che il lavoro agile non è una forma di assistenzialismo ma una forma di organizzazione del lavoro basata su criteri differenti. Poi, bisogna evitare i limiti predefiniti di posti, che generano soltanto malcontenti, una stupida competizione tra lavoratori e un’inutile spaccatura tra presunti privilegiati e discriminati. Occorre monitorare gli obiettivi e il loro raggiungimento e mettere da parte le assurde fasce orarie e i giorni predefiniti di rientro in ufficio. Un’organizzazione del lavoro che privilegi gli obiettivi non può prevedere le fasce di operatività, di contattabilità e di inoperabilità: sarebbe una vera e propria contraddizione. L’unica deroga ammessa potrebbe riguardare quei lavoratori che erogano dei servizi in orari prefissati. Infine, c’è una questione aperta che riguarda la domanda e l’offerta di servizi in relazione alle competenze digitali della popolazione: difficilmente si potrà attuare una diversa organizzazione del lavoro, se i cittadini continuano a considerare i servizi pubblici come “luoghi” fisici in cui recarsi e non come piattaforme digitali a cui far affidamento. La chiave di svolta dello smart working è la trasformazione digitale, che, di fatto, rende l’ufficio uno spazio inadeguato allo svolgimento di molti lavori.